Da anni ho deciso di focalizzare la mia attenzione sui territori ancor prima che sulle singole aziende e sui loro vini. I focus di quest’anno mi hanno portato a toccare svariati areali e molteplici denominazioni dell’enografia italiana ma ho deciso di riportare qui di seguito le zone (siano essi aree vitivinicole, denominazioni o specifiche unità zonali delle stesse) che di più hanno spiccato per alcuni fattori che reputo fondamentali per la mia attuale ricerca: vocazione, futuribilità della viticoltura locale (ovvero la capacità di sopperire alle difficoltà indotte dai cambiamenti climatici e dalle sfide commerciali odierne e future) e la capacità dei produttori locali di interpretare la propria identità territoriale in maniera nitida e contemporanea, senza storture o sovrastrutture di sorta. Un particolare riguardo, inoltre, è stato dedicato a quei territori che hanno evidenziato una prospettiva coesa e una visione condivisa grazie all’unità dei produttori che vi operano e al confronto tra gli stessi. In ultimo, si è rivelato elemento distintivo di alcune delle zone scelte una buona integrazione delle nuove generazioni.
Eccovi i territori vitivinicoli italiani su cui puntare nel 2024
Lamole – Vigne, vini e genti dalla spontanea eleganza

Ho sempre sostenuto di essere enoicamente laico e continuo a voler credere di poter mitigare l’effetto dei condizionamenti emozionali, umani, sulle mie considerazioni nei riguardi di territori, cantine, vini e vignaioli/e. Eppure, a latere di tale convinzione, non posso che ribadire quanto lo stimolo a voler continuare a fare ciò che faccio, come lo faccio risieda principalmente nella meraviglia, nello stupore e nella capacità di quegli stessi territori, quelle stesse cantine, quegli stessi vini e, soprattutto, quelle stesse persone di sorprendermi. Essere sorpresi, però, si fa cosa sempre più rara quando si viaggia, si assaggia e ci si confronta da tempo e si tratta di temi che, per quanto variegati e aggiornabili, girano sempre attorno allo stesso soggetto: il vino. Ecco perché non è stato arrivando a Lamole la prima volta che quell’incanto mi stupì davvero. Fu la seconda e ancor più la terza, senza parlar della quarta e della quinta, che mi meravigliò a tal punto da tramutare quella che sembrava una mera infatuazione nell’amore più sincero, ovvero quello che ha una base razionale che supporta e sostiene l’irrazionale emozione provata di fronte a quegli alberelli, a quegli scorci, a quei vini leggiadri eppure energici, che non mancavan di nulla. A quegli individui, così dediti alla vigna e alla custodia di uno dei beni più preziosi che si possano avere nel vino e nella vita: l’identità. Nell’ottica della recente zonazione del Chianti Classico e della definizione delle 11 UGA (unità geografiche aggiuntive) quella di Lamole è in assoluto la più piccola e la sua dimensione contenuta permette di identificare dei comuni denominatori fondamentali per comprendere quali siano le peculiarità pedoclimatiche generali e i loro effetti sulla matrice organolettica dei vini, al netto delle singolarità microzonali e della stilistica della specifica realtà produttiva.
Trovate alcune mappe qui: Lamole – Identità, classe e futuribilità di una “enclave” unica al mondo, apice espressivo del Chianti Classico
Lamole può vantare anche delle ideali “sottozone” interna all’areale quali: Casole, Castello di Lamole, Lamole, Le Masse, Case Poggio, La Villa e Le Volpaie, in cui si vanno a innestare, inoltre, alcuni “cru” quali Grospoli, Le Stinche, Campolungo, Poggio all’Olmo ecc…
I vigneti, storicamente adagiati su terrazzamenti rubati ai ripidi pendii dell’alta collina, si distribuiscono su un unico versante esposto in prevalenza a est, con un’altitudine media che si attesta tra i 400 e i 500m slm, con picchi vicini ai 700m slm. A distinguerla ulteriormente dal resto della valle della Greve, a cui di fatto appartiene, è anche l’integrità del contesto paesaggistico-naturale e la sana alternanza fra boschi (qui presenti in abbondanza tanto da dover cercare i vigneti fra i loro abbracci), oliveti e pascoli, con le coltivazioni di Giaggiolo a colorarne il maggio e a ricordarne la particolarità climatica. Un mesoclima fresco che unitamente al microclima delle terrazze in cui matrice pedologica, alberelli lamolesi (laddove persistano) e muretti a secco rappresentano un caso di studio in quanto capaci di condizionare escursioni termiche e fasi fenologiche della vite in maniera importante e percettibile. I terreni di Lamole possono contare maggiormente sulla formazione del Macigno, un’arenaria non calcarea caratterizzata da elevate percentuali di sabbia, non mancano inserzioni evidenti di Galestro (Es.: nella zona più alta de “Le Masse”), a differenza della maggior presenza di galestro e alberese a Radda e della pietraforte a Panzano. Un piccolo ritaglio di terra, da guadagnare sia per chi lo ha reso coltivabile e lo preserva tutt’ora utile alla viticoltura che per chi vuole raggiungerlo per godere delle sua unicità, proprio come sottolineava Emanuele Repetti (1833) sostenendo che Lamole si potesse raggiungere soltanto a piedi ma anche che “le viti piantate fra i sassi di cotesto poggio danno il buon vino di Lamole contano lodato”. Eppure, ciò che rende, a mio parere, Lamole una delle terre da vino più interessanti al mondo e il vero “Grand Cru” del Chianti Classico sono due fattori fondamentali nella mia ricerca enoica odierna:
–La contemporaneità dei vini: interpretazioni di Sangiovese (e dei suoi gregari, specie se parliamo di “vecchie vigne”) capaci di preservare caratteristiche e dotazioni analitiche di serie messe a dura prova dagli esiti dei cambiamenti climatici in altre zone, come la finezza, l’agilità e la possibilità di portare nel calice uno sviluppo aromatico in cui il fiore e la speziatura naturale (per me marcatori imprescindibili dell’eleganza) non siano mai occlusi e surclassati dal frutto e/o dall’opulenza.
-La futuribilità della viticoltura: nonostante le criticità di una gestione onerosa e della spezzettata parcellizzazione dei vigneti, la viticoltura lamolese si sta dimostrando in grado di mantenere delle costanti difficilissime da mantenere in altri areali, con cicli vegetativi lunghi e maturazioni lente e costanti, senza particolari stress della pianta e una capacità di resilienza, in particolare degli alberelli, di gran lunga superiore a quella del resto della denominazione. La speranza è che il ricambio generazionale, la nascita di nuove piccole e virtuose realtà, nonché l’arrivo di produttori e investitori da altre zone possano dimostrare quanto Lamole possa permettersi di restare sé stessa, con una minima ma fondamentale sensibilità nell’adattare la propria forma mentis al cambiamento climatico ma senza mai snaturare la propria essenza che fa della classicità della sua spontanea eleganza un valore che non potrà mai passerà mai di moda.
Nel mio ultimo focus sulla zona, finalizzato alla preparazione di un importante seminario sul tema della “contemporaneità dei vini di Lamole nell’era dei cambiamenti climatici”, ho avuto modo di approfondire la conoscenza del territorio visitando, una per una, tutte le realtà dell’associazione di viticoltori locali “I profumi di Lamole”. Trovate le mie considerazioni a riguardo qui:
In conclusione, l’enclave di Lamole è, oggi, uno dei territori del vino italiano con l’identità più marcata e riconoscibile, seppur mai ostentata. Un’area che ha tutte le carte in regola per anelare a risultati ancor più importanti in termini di eleganza e posizionamento, restando fedele a sé stessa e garantendo una futuribilità della viticoltura che va di pari passo con le esigenze agronomiche, enologiche e di gusto in divenire. I nuovi investimenti dall’”esterno” e, ancor più, la rinnovata consapevolezza degli stoici produttori locali rappresentano l’humus di una seconda giovinezza di questo territorio, in un contesto in cui dimensioni, singolarità pedoclimatiche zonali e parcellari e sensibilità nei confronti del rispetto dalla vigna al bicchiere permettono a Lamole di stagliarsi con orgoglio ma senza superbia all’orizzonte del vino del futuro. Sì, perché di Lamole si può e si deve riconoscere il passato e apprezzare il presente ma anche e soprattutto cogliere le opportunità future, perché saranno quelle che permetteranno a questo manipolo di virtuosi vignaioli e produttori di ritagliarsi un ruolo di prim’ordine nel panorama dei grandi vini italiani e del mondo, con finezza, slancio e spontanea eleganza.
Sannio – Un caleidoscopio vitivinicolo che può e sa ancora sorprendere
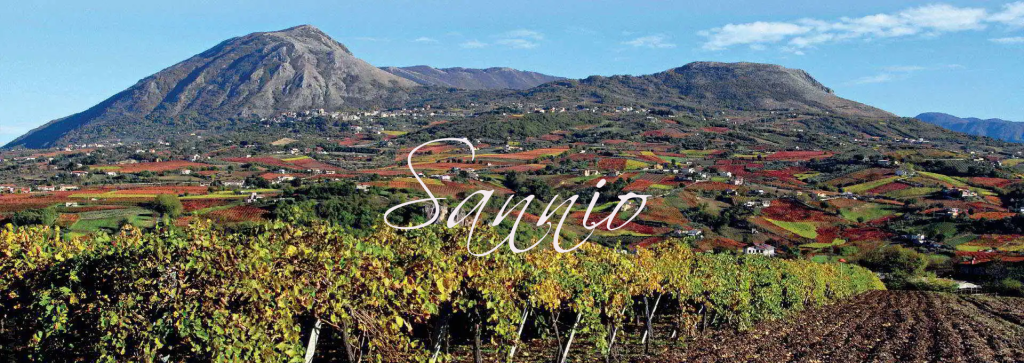
La Campania è una delle regioni più complesse e affascinanti dal punto di vista enografico con pedologie, altimetrie e microclimi differenti e sfaccettati e una base ampelografica a trazione rigorosamente “autoctona” unica al mondo per varietà e storicità. Storia che vuole il Caucaso come culla del vino indoeuropeo e proprio la Campania come crocevia e bacino strategico di diffusione dei varietali portati da greci e fenici nell’Europa occidentale. Una regione che da sola arrivò a vantare un numero di varietà locali superiore a quello dell’intera Francia. Ecco quindi che non è difficile approcciare nei vigneti campani cloni e biotipi differenti, resistiti grazie alla propagazione tramite selezione massale da parte dei vignaioli locali. Faccio questa premessa perché è proprio in Campania che vi porterò oggi e lo farò focalizzandomi sull’areale che rappresenta storicamente il vero polmone vitivinicolo della regione: il Sannio. Un areale vasto, che consta di ca. undicimila ha di vigneto e ospita più di 160 cantine ponendosi come principale area vitivinicola dell’intera regione.
E’ nella provincia di Benevento, infatti, che viene prodotta più della metà del vino campano a denominazione. Spiccano i comuni di Solopaca, Castelvenere (il più vitato della Campania), Guardia Sanframondi, Torrecuso (cuore pulsante dell’areale del Taburno) e Sant’Agata de’ Goti (dimora storica della Falanghina). Terre votate alla viticoltura dunque, disegnate dall’uomo in maniera ordinata e rispettosa, tanto da far strabuzzare gli occhi a chi, per la prima volta, si approccia a questo areale e percorre le strade che attraversano la Valle Telesina e costeggiano queste rigogliose colline. Vigneti nei quali si può trovare una base ampelografica decisamente ampia: l’Aglianico e la Falanghina come varietà maggiormente diffuse e Piedirosso, Sciascinoso, Barbera del Sannio o Camaiola (da non confondersi con quella piemontese), Fiano, Greco, Malvasia e Coda di Volpe tra i vitigni tipici che ancora resistono e insistono sul territorio. Non mancano contaminazioni interregionali e internazionali frutto di dinamiche che hanno spinto conferitori e produttori a impiantare Sangiovese, Montepulciano, il Trebbiano, il Moscato e, seppur in minor misura, Merlot, Cabernet Sauvignon e Chardonnay.
In misura minore, ma ancora presenti in alcuni vigneti, troviamo il Sommarello, l’Agostinella, il Cerreto, la Passolara di San Bartolomeo, l’Olivella, il Carminiello, la Palombina, il Moscato di Baselice e altri vitigni storici dei quali si sta cercando di tutelare il patrimonio genetico. Una tavolozza che ha permesso e permette tutt’ora alle realtà locali di interpretare il proprio territorio attraverso colori differenti ma sempre nel rispetto della sua forte identità pedoclimatica. Vini che ricadono nelle 5 denominazioni dell’areale: DOP-DOCG Aglianico del Taburno; DOP-DOC Falanghina del Sannio (Sottozone: Guardia Sanframondi o Guardiolo; Solopaca; Sant’Agata dei Goti; Taburno); DOP-DOC Sannio (Sottozone: Guardia Sanframondi o Guardiolo; Solopaca; Solopaca Classico; Sant’Agata dei Goti; Taburno); IGP-IGT Beneventano; Extra: IGP-IGT Dugenta.
Ciò che colpisce, a prescindere dai meri numeri, è la positiva convivenza nel Sannio fra realtà vitivinicole di diversa entità, talvolta antitetiche per dimensioni e prospettive commerciali, eppure sempre più allineate nel voler elevare la percezione di un areale dal potenziale ancora solo parzialmente esplorato ed espresso. Ciò che è emerso da visite in vigneto e in cantina, dalle occasioni di assaggio e dal confronto con i produttori che in prima persona operano sul territorio, è una quadro sfaccettato, complesso ma, al contempo, dai contorni nitidi, netti e ben definiti che tracciano uno stato dell’arte sicuramente positivo ma, ancor più, lasciano intravedere una tensione prospettica orientata verso un innalzamento comune e coeso dell’asticella. Proprio per questo, quest’anno, ho deciso di inserire il Sannio tra i territori sui quali puntare maggiormente, seppur non sia di certo un outsider.
Albugnano – L'”alto” Nebbiolo del “basso” Monferrato

Tra la miriade di micro-denominazioni italiane poche hanno, a mio modo di vedere, connotazioni e peculiarità utili a definirne singolarità e identità tali da conferire un’inappuntabile ragion d’essere a una così circoscritta “dimensione” vitivinicola e pedoclimatica in primis ma anche storico, culturale e antropologica. Tra queste denominazioni spicca, anzi si staglia quella dell’Albugnano Doc, che fa capo a meno di 50ha vitati, dislocati in 4 piccoli comuni del basso Monferrato (basso di nome ma non di fatto!) dove si possono coltivare le uve Nebbiolo da cui nasce questo nostro vino: Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito e Pino d’Asti.
La storia vitivinicola di quest’area trova testimonianze storiche che arrivano sino al 1148 e si lega in maniera indissolubile alla meravigliosa Abbazia di Vezzolano e alle vicende dell’aristocrazia sabauda. Nel 1868 il Nebbiolo spumante di Albugnano viene premiato all’Esposizione di Asti. Ma è con il riconoscimento della DOC, Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, che l’Albugnano inizia la sua ascesa, pur mantenendo salda la sua natura di enclave.
Per quanto mi riguarda, però, ciò che rende l’Albugnano Doc interessante, oltre alla sua storia e alle sue dimensioni, è la sua contemporaneità e la futuribilità della viticoltura che insiste sul territorio, nonché dei vini capaci di tradurre in maniera nitida ciò che, oggi, cerco in un vino che deve mostrare con fierezza ma senza sovrastrutture la propria identità, senza scimmiottare chi ha maggior notorietà, massa critica e successo commerciale.
Un territorio che potremmo riassumere attraverso le sue principali caratteristiche:
-altitudine media dei vigneti: attorno ai 300 m slm con picchi di oltre 530 m slm;
– matrici pedologiche: i suoli di produzione poggiano su marne mioceniche (langhiano-burdigaliano) e sono di colore chiaro, di medio impasto, anche se i terreni a livello superficiale presentano a volte affioramenti tufacei alternati a percentuali sabbiose più evidenti;
-versanti: il primo, che confina con Castelnuovo Don Bosco, è più ampio e vitato; il secondo, verso Berzano San Pietro, è invece più boschivo, qui le pendenze sono spesso elevate e i vigneti occupano i versanti meglio esposti.
-meso-clima: l’altitudine è determinante e influenza fortemente i parametri analitici come pH e acidità, nonché lo sviluppo aromatico. Fondamentale, specie in questo periodo, è la piovosità. Analizzando i dati pluviometrici della Regione Piemonte, elaborati in seno alla caratterizzazione morfologica e pedologica della Barbera d’Asti, Albugnano risulta essere, infatti, uno dei paesi dove le precipitazioni sono più frequenti e abbondanti all’interno della Provincia di Asti. Anche le temperature medie risultano essere inferiori al resto della provincia, ma con significative differenze a seconda dell’altitudine a cui si rilevano i dati, specie in termini di escursione termica (più importante, ovviamente, a ridosso dell’epoca vendemmiale).
-Biodiversità: a differenza di altri contesti vitivinicoli – anche piemontesi – quello in cui insiste la Doc Albugnano è un areale di grande integrità paesaggistica, in cui la presenza di bosco è molto importante e ancora sussiste una sana alternanza agricola. Nell’ottica della tutela e della preservazione del patrimonio di biodiversità locale i produttori si stanno muovendo in maniera congiunta verso un approccio viticolo sempre più rispettoso e sostenibile
Queste peculiarità dell’areale, unitamente alla rinnovata sensibilità interpretativa dei piccoli produttori locali, divengono caratteristiche capaci di rendere questa piccola DOC un punto di interesse focale per il Nebbiolo odierno e per quello che verrà. Lo hanno capito bene i produttori dell’Associazione ALBUGNANO 549, nata per sostenere l’identità enologica, storica, culturale, ambientale e socioeconomica del territorio di produzione dell’Albugnano DOC. Associazione che porta nel nome i 549 metri di altezza del punto più alto del comune di Albugnano come a voler rimarcare uno dei numerosi vantaggi che questo territorio porta in dote. E’ proprio grazie alla coesione di questi produttori e alla futuribilità della viticoltura locale e delle peculiarità analitiche ed organolettiche dei vini ivi prodotti che punto anche sull’Albugnano per questo 2024 e non solo!
Rufina – “Terre elette” per storia e futuribilità della viticoltura

C’è una terra da vino in Toscana che vive sta vivendo un momento di slancio non indifferente ma che è ancora parzialmente frenata da preconcetti, deviazioni semantiche e una comunicazione fuorviante che ne hanno limitato, per anni, non tanto la qualità produttiva quanto la capacità di mostrarsi al mondo per ciò che è nella consapevolezza di esser compresa. Parlo della Rufina, piccolo areale in cui storia, vocazione, famiglia, dedizione, biodiversità e operosità si fondono da secoli per dar vita a vini classici e, oggi più che mai, contemporanei. Contemporaneità che non cozza con la storia del Chianti Rufina. Una storia comune a poche altre terre del vino, che può vantare una testimonianza certa della propria vocazione, ovvero il Bando di Cosimo Terzo de’ Medici che, nel 1716, delineò i confini della regione vinicola: Chianti (ora Chianti Classico), Pomino (ora Chianti Rufina e Pomino), Carmignano e Valdarno di Sopra. Questa proclamazione sanciva il terreno fertile e il clima temperato di questa zona come ideale per la coltivazione delle varietà tipiche al fine di produrre vini di pregio. Nel corso dei secoli, questo areale ha subito diversi accorpamenti, ma è nel 1932 che, grazie a un decreto ministeriale, è stata delineata la delimitazione territoriale attuale e la creazione delle sottozone, tra cui quella della Rufina.
Il Chianti Rufina si trova a soli 20 chilometri da Firenze, sul medio versante della Sieve, tra i comuni di Pontassieve, Rufina, Londa, Pelago e Dicomano. Questa zona è caratterizzata da forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, creando un clima ideale per la viticoltura. Le altitudini variano da 200 metri slm fino a 700 metri slm. Nello specifico in base alla classificazione di Koeppen (rivisitata da Pinna per l’Italia), l’area del Chianti Rufina è caratterizzata da un clima temperato sublitoraneo, con temperature medie annue tra 10 e 14,4 °C, un mese più freddo con medie tra 4 e 5,9°C, tre mesi estivi con medie superiori a 20°C e un’escursione termica annua di 16-19°C. Inoltre, l’area presenta un mesoclima appenninico interno, tipico della zona a rilievo dell’area a macroclima mediterraneo. All’interno del mesoclima possiamo trovare microclimi e veri e propri climat riconducibili alle caratteristiche dei vini ivi prodotti, con un range abbastanza ampio che va dai vini più concentrati e profondi a quelli più freschi e slanciati.
La pedologia è stata approfondita da un’indagine zonale condotta dal Prof. Scienza, utile ai produttori per dirigere al meglio le scelte d’impianto, cosa di cu tutti gli areali vitivinicoli dovrebbero disporre e che vi invito ad approfondire, unitamente ai termini del disciplinare della DOCG, qui: https://wineblogroll.com/2023/10/rufina-chianti-terraelectae-selezione-vini-territorio/.
Il Sangiovese è la varietà dominante ma per correttezza bisognerebbe parlare di “Sangiovesi”, data la varietà di cloni, biotipi ed ecotipi presente sul territorio anche all’interno dello stesso vigneto. Una profonda opera di restauro del parco vigna locale ha infatti portato alla nascita di impianti ben ponderati in cui le scelte di portainnesti, genetiche (preservando, laddove ne valesse la pena, il materiale di vecchi vigneti attraverso la selezione massale), sesti di impianto, potature (sempre più frequente la conduzione e/o la conversione a guyot, nonostante permangano ancora alcuni impianti ben gestiti a cordone) e approccio agronomico hanno reso possibile un maggior equilibrio e una prospettiva più concreta e ragionata della viticoltura del Chianti Rufina. Comprendendo la necessità di riferire la menzione “Terraelectae” al Sangiovese in purezza, non vi nego che – da par mio – non mi dispiacerebbe che in questa area, ancor più che in altre, si tornasse a valorizzare l’uvaggio classico di territorio, con quei pochi vecchi vigneti rimasti a raccontare in maniera molto chiara quanto la complementarietà varietale.
La “menzione vigna” (e quindi la varietà a disposizione della singola identità zonale) resta, comunque, il concetto portante di quello che è divenuto il progetto trainante nonché potenziale leva valorizzante dell’interno areale, ovvero: “Terraelectae”. Si tratta di quello che viene definito marchio collettivo volontario e mira a evidenziare, attraverso le singolarità micro-zonali, da un lato, la sfaccettata complessità del Chianti Rufina e, dall’altro, i comuni denominatori e la vocazione diffusa del territorio. Per farlo ogni azienda ha (o lo farà per chi ancora deve entrare a far parte del già folto novero di realtà coinvolte nel progetto), infatti, selezionato il vigneto più vocato e rappresentativo, impiantato esclusivamente a Sangiovese. Questi vini sono vinificati con regole uniformi e dotati del marchio “Terraelectae” che rappresenta uno step ulteriore alla tipologia Riserva (tutti i vini saranno, comunque, “Riserva”) e alla menzione “Vigna”: produzione max uva/ha 70 Q.li/ha; titolo alcolometrico non inferiore a 12,5%vol.; 30 mesi invecchiamento di cui 18 in legno e almeno 6 in bottiglia; divieto di utilizzo di recipienti tipo “fiasco” (si sta lavorando per potersi dotare di una bottiglia comune o comunque identificativa del progetto che, ad oggi, è riconoscibile “solo” per la menzione Terraelectae in etichetta).
“Il vino “Terraelectae” deve essere ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella zona di produzione Chianti Rufina DOCG e provenienti da vigneti in proprietà dell’Azienda o condotti in affitto o con titolo diretto di conduzione. Deve riportare in etichetta la menzione “Vigna” o “Vigneto”. Il vino deve essere tracciato, la vinificazione e conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati e tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento. In definitiva tutti i nomi dei vini Terraelectae seguiranno le regole del disciplinare per quanto attiene la Menzione “Vigna”, ma questo non comporta la necessità di istituire un registro apposito e diverso dai consueti registri di denuncia delle uve previsti dalla legge.”
Questo progetto ha richiesto molto lavoro da parte del Consorzio e ha permesso, però, di agire in tempi ristretti in quanto non ha apportato modifiche al disciplinare vigente, bensì lo ha usato come base e strumento per poter raggiungere un più alto standard qualitativo e di percezione. Ciò che farà la differenza, da ora in avanti, sarà – oltre all’ovvia qualità pretesa per questi vini – un riposizionamento importante di quella che deve essere non solo una punta di diamante per la Rufina, bensì una leva per alzare in maniera sensibile il prezzo medio di tutti i vini ivi prodotti che, attualmente, non gratifica i produttori e cozza con l’indubbia vocazione dell’area. Non a caso ho scelto di tornare in Rufina e di dedicare un focus a quest’area proprio nelle prime battute del progetto Terraelectae. Durante il mio tour ho avuto modo di visitare quasi tutti i vigneti selezionati per la produzione di queste vere e proprie selezioni e di confrontarmi con chi ha aderito e chi è in procinto di aderire a quello che potrebbe essere il volano per un territorio in cui, da sempre, si fa buon vino ma che rischiava di rimanere imbrigliato nel proprio stesso passato. Ecco perché, confrontandomi e assaggiando i vini che riportano in etichetta la menzione “Terraelectae” sono giunto alla conclusione che ciò che serve al Chianti Rufina non è rivangare il passato o far pedissequo sfoggio di storia e tradizione, bensì prendere coscienza di quelle peculiarità che rendono queste terre adatte a mitigare gli esiti dei cambiamenti climatici in atto sia dal punto di vista agronomico che enologico. Questo non significa rinnegare il passato (che va custodito e contemplato fra i valori intrinseci del territorio sia a livello antropologico che enoico a 360°) ma tenere solo ciò che di buono è possibile tradurre nel presente e, ancor più, nel futuro, con rinnovata consapevolezza tecnica e prospettive chiare, nitide e credibili. I vini parlano da soli: i Chianti Rufina, dai vini “classici” alle Riserve, fino ad arrivare ai “Terraelectae” incarnano in maniera spontanea e senza forzatura alcuna i canoni del vino contemporaneo, con gradazioni tendenzialmente più contenute, maggior freschezza e agilità di beva, ma con vigore e tonicità dati da nerbo, tannino e persistenza di gusto. Va da sé che le mie considerazioni sono generali e che tra le referenze assaggiate (più gli altri vini prodotti del territorio che non ricadono nella denominazione Chianti Rufina Docg, tra i quali spiccano bianchi e rosati di grande freschezza e precisione e vini orientati alla valorizzazione delle singolarità vocazionali di ciascuna “micro-zona”, come che spaziano da equilibrati blend tra sangiovese e internazionali a raffinati Pinot Nero, passando per tagli bordolesi che sanno più di territorio che del modello di riferimento) si palesano divergenze interpretative importanti che vedono alcuni puntare di più sulla concentrazione e la profondità, altri sulla finezza e la dinamica, ma tutti hanno in comune una predisposizione all’eleganza che non si può creare da zero e, soprattutto, va oltre le scelte stilistiche. Certo, l’eleganza può essere assecondata con attenzione, sensibilità e garbo dalla vigna alla bottiglia, ma credo che in questo momento di “start-up” del nuovo progetto e di un nuovo evidente corso dell’intera denominazione possa essere addirittura costruttivo avere la possibilità di confrontarsi su differenti cifre stilistiche, in attesa di una possibile e auspicabile convergenza.
Modigliana – La stella dell’Appenino, enclave romagnola di genuina finezza

Che Modigliana fosse una terra eletta in termini vitivinicoli non vi erano molti dubbi, ma che il piglio della sua avanzata enoica sarebbe stato così concreto e rapido non lo si poteva dare di certo per scontato. Un territorio capace di esprimere le proprie peculiarità micro-climatiche e pedologiche parcellari attraverso molteplici traduttori varietali e non solo dal più tipico Sangiovese, che resta alfiere e riferimento per tutte le aziende locali. Un’area di alta collina, a tratti più simile alla montagna, in cui le argille incontrano le marne, con microclimi cangianti a seconda dell’altitudine e della valle di riferimento. Sono proprio le tre valli a delineare una sorta di zonazione dell’areale che conta ca. 350ha in totale:
Ibola: si tratta della valle più fredda e più boschiva e anche della più corta e stretta, con vigneti che raccontano in maniera nitida quanto, in questo territorio, la viticoltura si sia integrata con rispetto e non poca fatica al contesto paesaggistico locale, mantenendo integra la grande dotazione di biodiversità. Qui i vini sono generalmente più severi, introspettivi, ma anche freschi e intriganti grazie a frutto e al fiore mai spinti a maturazioni eccessive e alla speziatura naturale tipica di zona in cui il Sangiovese può avere un ciclo vegetativo più dilatato e arrivare a vendemmia con forti escursioni termiche. Diverse sono le interpretazioni ma resta il comun denominatore che li rende netti, forti del proprio nerbo acido, fini ma non esili. La chiusura è tipica della zona e persiste con l’ematicità che rende così eleganti questi vini.
Tramazzo: è la valle più ventilata e anche qui le escursioni termiche non mancano. I vini di questa zona sono integri, ben bilanciati fra frutto, fiore e spezia, con folate mentolate e accenni ematici sin dal primo naso. Vini che coniugano una buona dotazione materica a una tessitura tannica ben definita, mantenendo un’ottima dinamica di beva e chiudendo lungamente saporiti.
Acerreta: la valle più vasta e quella che vanta le esposizioni più importanti. In questa zona il Sangiovese può raggiungere maturazioni più importanti ma sempre bilanciate fra struttura e acidità, con profumi più orientati alle espressioni fruttate, ma mai eccessive, grazie alla consueta speziatura e mineralità. L’aziende delle correnti provenienti dal mare mitiga le escursioni termiche solo parzialmente. Integri, fieri e ampi ma non di certo potenti o opulenti, vantano l’agilità tipica dei vini di Modigliana senza lesinare centro bocca ed ematicità spiccata. La tessitura tannica è finemente delineata.
Espressioni e di Sangiovese che rendono l’enclave a cavallo fra Romagna e Toscana una delle area più futuribili per la produzione della varietà che, in Italia, è più diffusa e, dunque, quella che vanta il maggior numero di declinazioni pedologiche, meso e micro climatiche, nonché stilistiche. Terre, vigne, menti e mani che possono proiettarsi in avanti consapevoli di poter gestire meglio di altri l’incidenza dei cambiamenti climatici che, però, purtroppo hanno manifestato tutta la loro imprevedibilità con le alluvioni di quest’anno, mettendo a dura prova Modigliana, provocando gravissimi danni alla viabilità, alle abitazioni e alle attività (comprese, ovviamente, quelle vitivinicole con frane che hanno interessato ampie porzioni di vigneto) e che, ancora oggi, ridisegnano il paesaggio della zona in maniera nefasta. Vini dalla duplice attitudine alla freschezza e alla prospettiva, in grado di mantenere salda la propria peculiare identità varietale e territoriale, conferendo percettibile riconoscibilità e riconducibilità a ogni referenza degustata negli ultimi anni. Oltre ai Sangiovese di Modigliana, però, a stupire è l’attendibilità delle traduzioni in bianco con vitigni storici (Trebbiano – min. 60% – e Albana) e varietà alloctone, ormai completamente acclimatate (Chardonnay e Sauvignon), che danno vita a incontri e varianti di grande contemporaneità e finezza, in cui slancio, agilità e sale vertono verso un conviviale garbo. Ulteriore conferma della vocazione di questo piccolo grande areale, poi, ci sono le “scommesse” ardite come il Pinot Nero o il Cabernet Franc selettivi per natura e ancor più se si richiede loro di anelare a quella forma completa e complessa, non stereotipata, che fa dell’equilibrio e della finezza le proprie imprescindibili doti.
Un vero e proprio “cru” romagnolo, capace di elevarsi a ben più di mera nicchia produttiva (con il 3% delle vigne di Sangiovese dell’intera Romagna Modigliana produce ca. il 25% dei vini che rivendicano una MGA), dimostrandosi atta alle sfide della viticoltura e dell’enologia contemporanea, portando nel calice vini mai stereotipati, fortemente identitari che fanno dell’equilibrio, dell’agilità di beva e della propensione all’eleganza le proprie peculiarità distintive. Il tutto senza le poco utili comparazioni con la sponda toscana e favorendo, piuttosto, il confronto tra le singolarità zonali e parcellari dell’areale, mostrando e dimostrando quanto, anche e soprattutto attraverso un sensibile e fedele lettore di “terra e cielo” come il Sangiovese, si possa anteporre la disquisizione di territorio a quella meramente varietale.
Serrapetrona – La Vernaccia Nera e le sue terre così care a Soldati e Veronelli

“Piove più forte quando arriviamo, affamati, a Serra Petrona. L’aspetto del luogo, cupo, roccioso, addossato ad un pendio ripidissimo e quasi in una gola montana, non tradisce la suggestione iniziale del nome. Ma la Vernaccia… la Vernaccia non esiste.”
Queste sono le parole che Mario Soldati dedicò alla Vernaccia Nera di Serrapetrona, nell’incipit del racconto del suo viaggio alla scoperta di questo straordinario vitigno delle Marche, che rischiava di estinguersi e di essere interpretata – a suo dire – in maniera poco identitaria ma che, oggi, sta vivendo un momento di rinascita che, seppur ancora agli albori, potrebbe darle il lustro che le spetta. Le parole di Soldati scaturirono dall’incontro con un ingegnere di Ascoli che, nel 1970, alla richiesta di informazioni riguardo la Vernaccia Nera di Serrapetrona, rispose più o meno così: “La Vernaccia? La Vernaccia di Serrapetrona non esiste più. Sono anni che sto cercandola. Non l’ho mai trovata”.
Questo la dice lunga su quanto prezioso sia il lavoro di preservazione e tutela, di ripropagazione e di valorizzazione di un varietale che ha nella sua storia e nel suo spettro organolettico, ergo nella sua genetica, qualcosa di tanto misterioso quanto affascinante. Sì, perché se è vero che l’ampelografia odierna sembra averne appurata la somiglianza con le varie accezioni di Grenache presenti anche nel nostro paese (vedi Cannonau, Tai Rosso, Gamay del Trasimeno, l’Alicante, il Nelson e persino – dicono – il corregionale “Bordò”), la Vernaccia Nera di Serrapetrona dimostra quanto il concetto di terroir in cui il territorio con il suo pedoclima, le sua componente antropica e la sua cultura agricola ed enoica, nonché le scelte tecniche in campo e in cantina, possano connotare in maniera definita, unica e identitaria un vino nel tempo. Che il tempo abbia, poi, portato anche a selezioni massali di cloni, o più probabilmente di biotipi differenti che si distinguono dalle “grenache” di cui possiamo disporre in altri areali è egualmente ipotizzabile e comprensibile, ma a prescindere da ciò che la Vernaccia Nera è nel suo DNA è ciò che la Vernaccia Nera riesce e può riuscire ad essere qui, a Serrapetrona, che la rende unica.
Un’unicità che parte dalla sua storia enologica che la vede oggetto di un’interpretazione unica nel suo genere, ovvero quella dello spumante più noto delle Marche (unico spumante rosso in Italia ad avere la DOCG) e che, in passato, ha riscosso un successo tale da renderla nota anche al di fuori dei confini regionali come l’unico spumante prodotto con tre fermentazioni. è l’unico spumante rosso al mondo che, per diventare tale, ha bisogno di 3 fermentazioni. Infatti, solo una parte delle uve viene vinificata subito dopo esser stata raccolta, mentre il restante (minimo il 40% del totale) viene messo ad appassire nei suggestivi locali colmi di grappoli letteralmente appesi ad asciugare fino a metà gennaio. Il mosto, derivante dall’uva passita, viene poi rigovernato nel vino di ottobre ed ecco la seconda fermentazione che porta alla base spumante. Dopo aver terminato la maturazione, viene effettuata la terza e ultima fermentazione naturale per la presa di spuma, che permette di ottenere uno spumante unico, di una sorprendente complessità aromatica, dolce o secco. Con il Natale alle porte, molte famiglie marchigiane porteranno in tavola una Vernaccia di Serrapetrona, magari dolce, ma questa tradizione così laboriosa e connotante (vi invito ad andare a Serrapetrona durante i giorni degli “appassimenti aperti” per lasciarvi suggestionare dalla bellezza dei grappoli appesi in appassimento) è stata con buone probabilità uno dei fattori limitanti dell’ascesa sia in termini agronomici che enologici di questa varietà. Nel nuovo millennio, però, grazie all’opera di lungimiranti enologici e produttori si è cercato di dare una dignità nuova alla Vernaccia Nera impostando i nuovi impianti e orientando il lavoro in cantina verso interpretazioni di vini rossi fermi declinati in vari modi, dal più fresco e agile al più complesso e “longevo”.
Queste interpretazioni ferme secche hanno messo in risalto un altra nota distintiva della Vernaccia Nera di Serrapetrona, ovvero la grande disponibilità di Rotudone, una particolare molecola identificata solo di recente (nel 2008) dall’Australian Wine Research Institute (AWRI) in grado di sviluppare il tipico aroma di pepe nero nei vini prodotti con alcuni varietali. Più tecnicamente il Rotundone è sesquiterpene biciclico presente nella buccia dell’uva (di alcuni varietali e in quantità differenti in base ai singoli cloni) che funge da precursore aromatico per lo sviluppo di questa nota speziata che molti hanno da sempre ricondotto al Syrah. Se è vero, infatti, che il varietale sul quale sono stati condotti i primi studi australiani è proprio il/lo Shiraz (nome australiano del/la Syrah) è pur vero che in Italia, a soli 3 anni di distanza, l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige ha portato avanti studi analoghi su vitigni autoctoni e alloctoni che notoriamente presentano questa caratteristica componente organolettica nel loro spettro aromatico. I vitigni presi in considerazione sono: Schioppettino, Vespolina, Groppello di Revò e Gruener Veltliner. Eppure, la Vernaccia ne è così dotata da dar vita a vini molto più “pepati” di molti altri.
Sia chiaro, per un marchigiano di queste terre come me, la Vernaccia di Serrapetrona spumante, ancor più nella versione dolce, avrà sempre un effetto evocativo e sinestetico al quale spero di non dover rinunciare mai, ma è palese che questo vitigno, oggi, possa e debba offrire delle interpretazioni di sé votate alla possibilità di mostrarsi grande fra i grandi, grazie alle “armi” dell’identità varietale spiccata e ai favori che il territorio di Serrapetrona, grazie ad altitudine e terreni, può ancora vantare nei confronti di un global warming che si fa sentire sempre di più, anche in queste zone. Di certo occorrerà adeguare costantemente la gestione agronomica (gestione della parete fogliare, eventuale riconsiderazione del cordone in favore del guyot, lavorazioni del suolo ecc…) ai tempi che cambiano, ma a Serrapetrona lo si potrà fare con maggior calma. Ciò che farà la differenza sarà l’impostazione di realtà che nella produzione di vini rossi fermi secchi facciano onore alle potenzialità del vitigno: sia nelle interpretazioni più “fresche”, nelle quali personalmente credo molto in quanto identificative del varietale e portatrici di un’identità di terroir più nitida e riconoscibile, andandosi ad innestare nel contesto di quei vini definibili “contemporanei” che stanno vivendo un momento di luminosità indiscussa; sia nelle versioni più orientate alla forza e alla longevità (nonché le versioni fresche non possano/sappiano evolvere bene…) con le quali siano possibili comparazioni nazionali ed internazionali in grado di elevarne la percezione su una fascia di posizionamento più alta. Staremo a vedere! Le prospettive ci sono e sono convinto che i tempi siano maturi per mostrare e dimostra che la Vernaccia Nera esiste, resiste e persiste!
Dopo aver aperto con le parole del grandissimo Mario Soldati, concludo con quelle di colui che lo aveva indirizzato verso Serrapetrona, ovvero Lugi Veronelli:
“Gran vino, degno di cru, degno di fama: colore rosso porporino, caratteristico personale sui generis largo e continuo bouquet, sapore dolce e tuttavia elegante, che va attenuandosi, sempre più spirituale, in bottiglia.”
Non aggiungo altro, se non l’invito ad assaggiare Vernaccia Nera di Serrapetrona in tutte le sue sfumature interpretative e, magari, a visitare questo luogo ameno, in cui il tempo sembra essersi fermato e il numero di ultracentenari è da guinness dei primati, tanto da far pensare che sia proprio il vino locale l’elisir di lungavita, ma questa è un’altra storia…
Mandrolisai – Nel cuore della Sardegna, il territorio prima della varietà

La Sardegna è, da anni, una delle regioni che di più ho avuto modo di visitare e approfondire in termini di vigna, cantina e vino ma a ogni mio viaggio mi rendo sempre più conto di quanto sia vasta, complessa e variegata la cultura vitivinicola sarda. Cultura declinata attraverso molte varietà, per lo più locali (spesso chiamate con nomi differenti in base alla zona di riferimento) e “in purezza”. Eppure, il cuore pulsante di quello che può essere definito, a tutti gli effetti, un continente enoico a sé stante, è così sincero, saggio e coerente dall’aver mantenuto un legame profondo con le sue radici vitivinicole antiche. Parlo del Mandrolisai, unica denominazione dell’isola ad aver mantenuto e messo a disciplinare l’uvaggio tipico di territorio, bypassando la moderna concezione (spesso forzata) del vitigno in “purezza”, anteponendo l’identità zonale a quella varietale.
Andiamo per ordine: il Mandrolisai, centro geografico della Sardegna, può contare, infatti, su una storia viticola radicata ancor più di quanto lo sono i, talvolta, vecchissimi alberelli. L’areale si estende nei terreni dei comuni di Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara e Desulo, Meana Sardo in prov. di Nuoro e Samugheo in prov. di Oristano La biodiversità regna sovrana e i vigneti vanno cercati tra macchia mediterranea, sugherete, pascoli e seminativo in una sana alternanza agricola, purtroppo sempre meno preservata in areali italiani in cui la viticoltura sta prendendo il sopravvento. A livello geo-pedologico i vigneti possono incontrare terreni principalmente bruni e litosuoli su graniti e scisti cristallini. Il clima è caratterizzato da temperature medie intorno ai 10°C e una media di pioggia annua da 700 a 900 mm, con l’altitudine a condizionare particolarmente l’escursione termica. I vigneti di questo areale, infatti, partono dai 300m slm per arrivare agli oltre 750m slm (con picchi di quasi 1000m slm fuori DOC, ma che non è escluso vengano reintegrati per via dei cambiamenti climatici). Il vitigno principale del Mandrolisai e quello più connotante nell’uvaggio “classico” (nonostante in termini di ettaraggio il Cannonau sia la varietà più diffusa con più del 60% della superficie) è il “Muristellu” o Bovale sardo, probabilmente originario della Spagna (“Morastel”) ma qui adattatosi in maniera ottimale, manifestando variabili genetiche dovute alle selezioni massali effettuate nel corso dei lustri dai vignaioli locali, capaci di propagare solo gli eco-tipi più performanti. Ci sono prove che suggeriscono l’importazione del vitigno dalla Penisola Iberica durante il periodo di dominazione aragonese. Dopo la fillossera, il Muristellu è stato reintegrato nella regione del Mandrolisai, in particolare nelle province di Sassari e nel centro dell’isola. Una varietà che, come testimoniato da vignaioli e produttori dei diversi comuni nei miei numerosi viaggi in zona, si fa sincera traduttrice delle singolarità zonali manifestando un range espressivo molto ampio e impattando in maniera differente nei vini della doc, determinando colore, struttura, nerbo e tessitura tipiche dei vini del Mandrolisai. Nei vini DOC il Muristellu incontra, quindi, il Cannonau e la Monica di Sardegna, con una percentuale variabile di ciascun vitigno e nello specifico: Bovale sardo o Muristellu non meno del 35%; Cannonau: dal 20% al 35%; Monica di Sardegna: dal 20% al 35%.
N.B.: Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve degli altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.
Se il Cannonau non ha bisogno di presentazioni e il suo apporto all’uvaggio o al vinaggio locale è funzionale all’equilibrio e alla riconducibilità ai vini dell’isola, come fosse un marcatore della sardità tout court, è la Monica (purtroppo meno presente di un tempo nei vigneti, ma reimpiantata da alcuni virtuosi e lungimiranti viticoltori) a rappresentare, a mio parere, una tra le uve più interessanti di tutta l’isola, nonché fattore determinante per definire l’eleganza e la finezza dei vini del Mandrolisai, attraverso il suo fragrante spettro floreale e la sua naturale e intrigante speziatura.
Le caratteristiche chimiche e organolettiche dei vini Mandrolisai sono fortemente influenzate dall’ambiente geografico, con vigneti in terreni di alta collina con esposizioni importanti e notevoli escursioni termiche giorno-notte, con vini che possono spaziare da percezioni organolettiche più orientate alla freschezza, dinamiche di beva più agili, a vini dal frutto più maturo e dalla struttura più potente (spesso corrispondenti alla menzione “Superiore” sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botti di legno, ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo di 12,50%). Fondamentale, in ambo i casi, è la spina dorsale acida e minerale che questi vini riescono a preservare ma ancor di più lo è e lo sarà (per via dei cambiamenti climatici) la possibilità di raggiungere equilibri e armonie sempre più difficili da ottenere con il monovarietale, mantenendo coerenza stilistica e grande identità territoriale.
La qualità dei vini Mandrolisai è il risultato dell’interazione tra l’ambiente geografico, i vitigni coltivati, le tecniche agronomiche ed enologiche. In merito a queste ultime, va detto che l’intervento umano, nel corso delle diverse ere enoiche, ha mantenuto e perfezionato le tradizionali pratiche di coltivazione e vinificazione senza ripudiare l’evoluzione tecnica, evidenziando proprio in questi ultimi anni (con prospettive di crescita palesi) una particolare attitudine ad attingere al passato senza il timore di guardare al futuro con contezza enologica e rinnovata sensibilità interpretativa, al fine di portare nel calice vini in grado di parlare di territorio in maniera nitida, coerente ma fortemente contemporanea. Sono proprio queste le peculiarità che mi portano a considerare il Mandrolisai come uno dei territori vitivinicoli più interessanti del nostro paese e, quindi, non solo di Sardegna. Un’area che gode dei presupposti per una viticoltura futuribile e non statica, che teme meno di altre gli esiti dei cambiamenti climatici (per quanto incidenti anche qui) e l’andamento di un gusto sempre più orientato all’eleganza, all’identità e a un dinamica di beva più agile.
In sintesi: adattabilità ai cambiamenti climatici, complementarietà varietale, crescente consapevolezza tecnica agronomica ed enologica, unitamente alla nascita di nuove e più efficienti strutture di vinificazione (anche per piccole realtà che non ne disponevano, per via della poca sostenibilità economica) e a un ricambio generazionale evidente nel numero di giovani presenti e nell’impatto che sta dando, sono e saranno i pioli di una scala destinata a portare il Mandrolisai ben più in alto di quanto si potesse pensare fino a qualche anno fa. Dal mio ultimo tour sul territorio è stata confermata la costante crescita della qualità dei vini del Mandrolisai, una diffusa pulizia e la sempre più contemporanea interpretazione dei vini di questo areale, naturalmente vocato e votato a una maggior slancio rispetto ad altre zone dell’isola.
In ultimo, ma non per importanza, ci tengo a menzionare i Rosati che, seppur ancora non riscuotano la fiducia di tutti i produttori locali, possono rivelarsi una chiave di lettura territoriale che, in un areale in cui sussistono alcuni vitigni a bacca bianca (utilizzati per produrre vini bianchi secchi e passiti) ma molti produttori sono “costretti” dal mercato a completare la linea con l’onnipresente Vermentino, può fungere da alternativa fresca e versatile mantenendo salda l’afferenza territoriale. Importante sottolineare che in questa denominazione la tipologia Rosato è presente in disciplinare e che, quindi, a differenza della maggior parte dei Rosati italiani, può rivendicare in etichetta il riferimento al proprio territorio (Mandrolisai Doc Rosato).
Chiudo con l’auspicio di trovare presto un consorzio a tutela dei vini del Mandrolisai (sembra sia in procinto di consolidarsi ufficialmente) che dia concreta evidenza di un lavoro di squadra e di una coesione che i produttori locali hanno dimostrato e mi hanno mostrato in più di un’occasione. Confronto, apertura e la giusta e sana competizione interna votata all’elevazione del territorio ancor prima che del singolo, sono le basi per il salto di qualità che, sono certo, il Mandrolisai stia già facendo e vi basterà assaggiare le nuove annate della maggior parte delle cantine e, ancor più, andare a trovare queste piccole realtà per comprendere a pieno il perché della mia grande fiducia nei confronti di queste vigne e di questi vignaioli.
Santa Maddalena / St. Magdalener – La versatilità del più “classico” dei vini dell’Alto Adige

Questo storico vino dell’Alto Adige nasce e sussiste nei vigneti adagiati sulle vocatissime colline e i pendii a nord della bellissima città di Bolzano. Parliamo di terreni ed esposizioni così ottimali da rendere l’areale classico del St. Magdalener il più vocato dell’intera regione. Le uve destinate alla produzione del Santa Maddalena (alla Schiava può essere aggiunto un piccolo saldo di Lagrein, solitamente non più del 5%) vengono coltivate su un totale di 200 ettari che corrisponde al 4% dell’intera superficie vitata in Alto Adige. Il sistema utilizzato in questa area è la classica pergola, costituita da pali verticali che sostengono un’impalcatura orizzontale alla quale vengono fissati i fili che reggono le viti. Ciò che caratterizza ulteriormente questo vino è la “tecnica” dell’uvaggio, ovvero la scelta di raccogliere, cofermentare e, quindi, vinificare le uve dei due varietali che concorrono alla sua produzione insieme, oggi come un tempo.
Parliamo di quello che, a tutti gli effetti, può essere definito il Consorzio di Tutela più antico d’Italia, perché nato nel 1923. Il “Consorzio di Tutela del Santa Maddalena”, infatti, si spende da quasi 100 anni per la salvaguardia di questo grande vino del territorio di Bolzano, oggi, coadiuvato dalla forza vitale dei giovani vignaioli che credono fortemente nelle potenzialità di questo areale e del St. Madgalener.
E’ importante sapere che tutti i vini prodotti da uva Schiava della zona di Bolzano rientrano nel Santa Maddalena, ma solo quelli prodotti dai vigneti (tra i più ripidi e soleggiati della provincia) situati all’interno del triangolo definito dal torrente Talvera, il fiume Isarco e il monte Tondo possono vantare (e riportare in etichetta) l’appellativo di Santa Maddalena Classico.
I vigneti tipici del S. Maddalena sono coltivati nelle zone più in quota (non parliamo di altimetrie altissime – tra i 200 e i 550mslm), trovano collocamento ideale nel terreno compatto, composto dai detriti che si raccolgono sui ripiani sagomati dai ghiacciai nell’ultima era glaciale. Nel quartiere di Rencio la Schiava trova un suolo di matrice sabbiosa ricco di ghiaia. Si tratta di terreni formati dal disfacimento del porfido quarzifero e dalle rocce metamorfiche antiche. Nel fondovalle, invece, lungo le rive del fiume Isarco, i vigneti affondano le proprie radici in sedimenti alluvionali di recente formazione. Un vitigno abbastanza resistente, di grande adattabilità, a cui ogni terreno dona una nota stilistica differente. Ad incidere particolarmente è il clima tipico della conca di Bolzano, caldo d’estate, ventilato e molto assolato. 300 giorni di sole complessivi all’anno sono il presupposto ideale per la viticoltura in Alto Adige. In particolare, le giornate estive asciutte e calde, alternate a notti piacevolmente fresche, e gli inverni relativamente secchi garantiscono cicli vegetativi equilibrati e maturazioni ponderate. Armonie propedeutiche alla produzione di vini dal buon bilanciamento acido-strutturale e dalle ottime prospettive in termini di eleganza e finezza.
Durante i miei ultimi focus sul territorio ho avuto modo di visitare vigneti e approfondire la conoscenza di vignaioli, produttori e tecnici che hanno saputo mostrarmi e dimostrarmi le peculiarità fondamentali e non scontate del Santa Maddalena:
– Una freschezza di frutto e un’agilità di beva rare, che non prescindono – oggi – una buona struttura che, nonostante il colore scarico possa indurre in errore, è in grado di dare integrità al sorso. Vini dall’impatto olfattivo completo in cui frutto, fiore e naturale speziatura trovano rare armonie.
– Un’ottima versatilità in termini di abbinamento. Consiglio di “giocare” sia con versioni differenti di Santa Maddalena (dalle versioni “classiche” alle selezioni) che con temperature di servizio calibrate in base al periodo e all’abbinamento. Potreste servire un intero menù abbinando solo dei Santa Maddalena senza rischiare di annoiarvi o di incorrere in una batteria di vini monocorde.
– Una longevità che stupisce per l’eleganza e la complessità che riescono ad ottenere Santa Maddalena di oltre 30 anni. In molti non credono che il Santa Maddalena debba necessariamente “invecchiare” e io sono tra quelli che ha sempre amato berli “giovani”, ma ciò non toglie che la capacità di saper evolvere in maniera così nitida ed elegante rappresenti un certo valore aggiunto al pedigree di un vino che ha fatto la storia dell’Alto Adige e deve continuare a farla.
– Un vino attuale, capace di essere apprezzato da giovane (dal secondo anno dalla vendemmia inizia ad esprimere a pieno la sua personalità) e di stupire nelle sue evoluzioni di anno in anno. Questa è la sua dote più importante, a mio parere, in quanto non sono molti i vini italiani in grado di rispondere in maniera così aderente alle esigenze dei palati nazionali e internazionali che – per fortuna – necessitano sempre di più di vini che sappiano coniugare una forte matrice identitaria, una struttura equilibrata né eccessiva né esile e una dinamica di beva così agile e piacevole, senza ostacoli di sorta ma mai scontata.
Tutto questo è possibile grazie al lavoro delle realtà che insistono sul territorio che negli anni hanno saputo portare avanti un approccio che attinge alla tradizione valorizzandola non in maniera pedissequa, bensì interpretandola con le consapevolezze e le competenze tecniche odierne, dalla vigna al bicchiere. E’, inoltre, interessante quanto ciò che potrebbe sembrare anacronistico e superato come la pergola, rappresenti un sistema di allevamento ideale per contrastare gli effetti e gli esiti dei cambiamenti climatici ormai evidenti anche e soprattutto in una zona tendenzialmente calda come la conca di Bolzano. L’altezza da terra che salva i germogli da eventuali gelate tardive, l’ombreggiamento offerto dalla copertura fogliare del “tetto” della pergola e una gestione ponderata delle rese rappresentano condizioni ideali per trovare equilibri sempre più complessi anche in annate in cui il global warming si fa sentire particolarmente.
Insomma, la Schiava e il St. Magdalener / S. Maddalena rappresentano un esempio nitido di quanto il passato che avevamo rinnegato alla fine del millennio scorso possa tornare ad essere non solo apprezzabile in quanto simbolo di tradizione, bensì per la sua contemporaneità. Sento quindi di fare un sincero plauso ai produttori di questo suggestivo e vocato areale per la caparbietà e la coerenza con le quali hanno portato avanti la loro idea di vino senza snaturarsi o “svendersi” alla prima moda, preservando un’identità varietale e territoriale che si rileverà sempre attuale e che nessuno potrà mai cercare di emulare.
Ciò che potrebbe stupire e che rende tutto ancora più interessante dal punto di vista enoico e antropologico è che tutto questo avvenga attorno alla più importante città della regione: Bolzano. Poi, però, ci si rende conto di quanto l’interazione e l’integrazione fra viticoltura e vita cittadina siano forti e radicati, tanto che Bolzano è considerata una delle città con la più alta qualità di vita ed è costantemente fra le prime tre più green in Italia e una delle più green in Europa. Attorno ai due varietali autoctoni che concorrono alla produzione del Santa Maddalena, Schiava e Lagrein, sono sorte negli anni ben 28 cantine e, a differenza di ciò che accade nel resto dell’Alto Adige, la maggior parte di esse sono ancora a gestione familiare, con una cantina sociale (alla quale conferiscono piccolissimi e virtuosi vignaioli) che opera in sinergia con il resto dell’indotto vitivinicolo e non vanta un’egemonia esclusiva come accade in altre aree non troppo distanti da qui. Se c’è un vino che, più di altri, si sta dimostrando capace di accomunare identità territoriale al concetto di contemporaneità del gusto credo sia proprio questo!
Riviera Ligure di Ponente – Vini tra mare e montagna

C’è una lingua che guarda al mare spesso poco considerata in termini vitivinicoli ma che vanta una concentrazione di unicità propria solo dei grandi territori. Parlo della Liguria e in particolare della Riviera Ligure di Ponente, una fascia collinare affacciata sul Mar Ligure che racchiude in pochi km, tra le province di Savona ed Imperia, vigneti e varietali dal potenziale ancora solo parzialmente esplorato seppur siano carichi di storia.
La Riviera Ligure di Ponente gode degli influssi benefici del Mar Mediterraneo e della protezione delle Alpi, con valli strette e ripidi pendii che impongono una viticoltura per lo più virtuosa e in molti casi eroica.
In questo areale così contenuto troviamo una ricchezza di varietali capaci di esprimere il territorio con sfumature e declinazioni fortemente identitarie come: il Pigato, il Vermentino, la Lumassina, il Moscato (Moscatello di Taggia), la Granaccia e il Rossese di Dolceacqua (al quale si aggiunge l’ormai quasi perduto Rossese di Campochiesa) e il Dolcetto “di montagna” ovvero l’Ormeasco di Pornassio.
E’ proprio girando per vigne e cantine che ho avuto modo di comprendere quanto la generalizzazione in questo areale sia impossibile anche in termini varietali con il Pigato che pur essendo stato avvicinato in termini genetici al Vermentino vanta espressioni completamente differenti, specie se si parla di cloni più antichi. Lo stesso vale per la Granaccia che si distingue fra vecchi biotipi (purtroppo ancora presenti solo in alcuni vigneti) e la più “comune” Grenache che possiamo incontrare negli impianti più recenti. Poi c’è la storia del Rossese che si divide nel più noto Rossese di Dolceacqua (ormai sempre certa la stretta parentela con il Tibouren francese) e nella varietà ormai quasi del tutto perduta denominata Rossese di Campochiesa, più snella e potenzialmente molto interessante nell’epoca odierna ma di certo abbandonata per via delle sue caratteristiche sin troppo “esili e fini” che in altre “ere enoiche” venivano percepite come negative.
Nello specifico le denominazioni rivendicate dalle aziende di Vite in Riviera sono le seguenti:
Riviera Ligure di Ponente Doc: Pigato, Vermentino, Moscato (e/o Moscatello di Taggia), Rossese, Granaccia; Rossese di Dolceacqua Doc; Pornassio o Ormeasco di Pornassio Doc; Terrazze dell’Imeriese Igt, Colline Savonesi Igt.
Vermentino & Pigato
Per quanto concerne la Doc Riviera Ligure di Ponente è evidente il traino del Vermentino in termini di numeri e di richiesta, ma ha rappresentare in maniera nitida il territorio è, senza tema di smentita, il Pigato che vede le quote di mercato allargarsi e la qualità diffusa salire in termini di espressività varietale ma anche e soprattutto in quanto a interpretazione del singolo produttore. Se fino a qualche anno fa il Pigato veniva proposto solo come vino d’annata, da bere fresco, magari durante le vacanze in Riviera, oggi sono numerose le aziende che stanno cercando di spingere questo vino verso la percezione che merita, innalzando la qualità tramite maggior attenzione in vigna, rese più basse, vinificazioni più attente (fondamentale l’affinamento sulle fecce fini) e, in alcuni casi, decidendo di far uscire il proprio vino con un affinamento in bottiglia più lungo in modo da poter dimostrare quanto il Pigato sappia dare tra il secondo e il terzo anno di dalla vendemmia. Complessità varietali votate non più al solo frutto fresco e alle sfumature floreali, ma anche alla mineralità (non è rara la presenza di TDN che avvicina il naso di molti Pigati al Riesling) e ad una più marcata profondità di sorso, non così scontata per un vitigno che non vanta un’altissima acidità di base ma di certo può giocarsi la carta dell’agilità grazie alla grande sapidità che fa da comun denominatore per l’intero territorio. Se il Vermentino può essere un passepartout grazie alla maggior conoscenza del varietale da parte dei consumatori italiani e stranieri, torno dalla Riviera Ligure di Ponente convinto che sia il Pigato la vera scommessa di questo areale, capace di esprimere le singolarità grazie alla sua diffusione in vigneti propri di ogni sottozona. In un’epoca in cui la ricerca delle nicchie d’eccellenza e dei varietali autoctoni è, fortunatamente, cresciuta la mission delle realtà del territorio e di reti come Vite in Riviera deve necessariamente essere far conoscere questo vino e innalzarne la percezione anche in termini commerciali.
Ormeasco di Pornassio
Altra unicità, seppur il vitigno possa sembrare “fuori casa”, è l’Ormeasco di Pornassio, che amo definire “il Dolcetto di montagna”, anche se a rigor di logica dovremmo parlare di alta collina.
Per me che amo la viticoltura d’altura andare a scoprire vigneti che si spingono dai 600 agli oltre 800m slm in Liguria è stata un’esperienza fondamentale per comprendere ancor più approfonditamente quanto siano variegate e sfaccettate le potenzialità di questa regione e di questo specifico areale.
Qui il Dolcetto dal raspo rosso affonda le proprie radici nei depositi alluvionali di ghiaia e sabbia che tanto vocata rendono questa terra. La grande escursione termica giorno-notte fa il resto, regalando all’Ormeasco finezze aromatiche e freschezza impensabili altrove.
Oltra al Rosso e Rosso Superiore, mai troppo carichi di colore, ben bilanciati fra struttura e acidità e dinamici al sorso, con chiusure molto saporite di sale e di ferro, c’è uno dei Rosati più interessanti dell’intera penisola, ovvero l’Ormeasco Sciac-trà (“schiaccia e trai”) che viene prodotto con una brevissima macerazione post-pigiatura, quindi non per salasso. E’ evidente che questo Sciac-trà nulla abbia a che vedere con lo Sciacchetrà delle Cinque Terre.
L’Ormeasco di Pornassio, nonostante i numeri contenuti della sua produzione, può rappresentare un’ulteriore veicolo di interesse nei confronti della viticoltura della Riviera Ligure di Ponente, offrendo contesti suggestivi sia in termini di viticoltura che di espressività organolettica.
Granaccia Ligure
Tra le varie derivazioni della Grenache che possiamo incontrare in tutto il territorio italiano (vedi Tai Rosso, Vernaccia Nera di Serrapetrona, Gamay del Trasimeno, Cannonau ecc…) la Granaccia Ligure è quella che meno ha “nascosto” la sua parentela con il noto vitigno francese (che a sua volta sembra provenire dalla vicina Spagna (probabilmente dalla Catalogna o dall’Aragona). Eppure i vecchi cloni trovati in alcuni vigneti di Quiliano sembrano asserire con forza che la Granaccia “originale” di queste zone, ovvero quella più tipica, è ben distinta dalla Granaccia/Grenache impiantata nel corso degli ultimi anni in molte sottozone della Riviera Ligure di Ponente e non solo.
Ecco perché troveremo: da un lato pochi vini prodotti con questi tradizionali cloni presentarsi più scarichi nel calice, con aromi più votati al fiore che al frutto, un’intrigante speziatura naturale. maggiori finezze e un’acidità più marcata, con chiose ematiche evidenti; dall’altro una maggior diffusione di vini più carichi, con maggior estratto, ben bilanciati fra corpo e freschezza, con un profilo organolettico più intenso e denso, sicuramente più vicini alle interpretazioni spagnole del vitigno.
Vedo in queste due espressioni di quello che per convenzione è considerato lo stesso vino una possibilità interessante ed intrigante che va ad arricchire ulteriormente di varietà la proposta enoica di questo piccolo areale. Inoltre, la presenza dei cloni storici può rappresentare un termine di paragone importante che, attraverso la comparazione, può e deve portare – a mio avviso – a riconsiderare alcune interpretazioni di Granaccia, oggi, forse anacronistiche in quanto troppo ricche e morbide.
Rossese di Dolceacqua
Il mio viaggio alla scoperta e alla ri-scoperta delle sottozone della Riviera Ligure di Ponente e delle sue eccellenze enoiche non poteva che portarmi fino al micro-areale del Rossese di Dolceacqua, storico vino ligure, capace di ritagliarsi nicchie di interesse sempre maggiori negli ultimi anni, grazie all’opera di virtuosi produttori capaci di trarre dagli antichi terrazzamenti sui quali poggiano per lo più vigne per lo più eroiche per la loro pendenza, vini di grande eleganza.
Il Rossese di Dolceacqua è allevato da secoli in provincia d’Imperia, per lo più con il sistema dell’alberello ligure, ancora presente in molte particelle dei vigneti della denominazione, con ceppi che oltrepassano persino i 100 anni di età.
Solo recentemente è stata evidenziata la stretta parentela con il varietale francese Tibouren coltivato in Provenza, ma la diversità di biotipo e il suo adattamento a questo territorio e al tipico terreno scisto-marnoso ha portato il Rossese di Dolceacqua a maturare una sua propria espressività.
Nonostante la particolare sensibilità del vitigno alle principali patologie della vite (specie quelle enfatizzate dall’umidità) il clima sempre più arido ma al contempo la mitigazione del mare e le escursioni termiche date dall’altitudine, stanno offrendo scenari interessanti per gli abili vignaioli del Rossese di Dolceacqua che negli ultimi anni hanno portato in bottiglia vini sempre più interessanti in termini di armonia e potenziale di longevità, specie nelle versioni Superiore.
La delicatezza del vitigno, la difficoltà di gestione dei vigneti impervi e alcune particolarità come la tendenza all’acinellatura del grappolo del Rossese di Dolceacqua avevano fatto quasi scomparire questo vitigno dalle campagne di questa circoscritta area della Riviera di Ponente, ma come per il Pigato anche in questo caso l’obiettivo dei piccolo produttori locali è e deve necessariamente essere la valorizzazione del vino anche in termini economici elevandone la percezione e, quindi, la remunerazione.
Il problema di fondo delle aree che ho avuto modo di visitare e dell’intera produzione vitivinicola della Riviera Ligure di Ponente è proprio la scarsa redditività delle aziende che hanno consapevolmente assecondato un periodo di stallo dato dalla “facilità” commerciale indotta dalla vendita agli esercizi locali e alle regioni limitrofe (Piemonte e Lombardia fra tutte). Questo non ha permesso uno sviluppo più rapido del territorio che potrebbe aumentare i numeri mantenendo la alta la qualità dei vini prodotti solo avendo una maggior remunerazione in bottiglia.
La mia personale percezione è che la qualità sia cresciuta notevolmente e che, anche grazie ad associazioni come Vite in Riviera e quindi al confronto fra le singole aziende e i singoli produttori, si stia maturando una maggior consapevolezza nei propri mezzi e una visione più ampia del potenziale di questa area della Liguria.
Custoza Doc – La sfida di ri-posizionarsi grazie al Superiore

Durante questo 2023 mesi ho deciso approfondire la produzione di una Doc bianchista di cui, mea culpa, avevo avuto modo di degustare molto poco negli ultimi anni. Parlo della Doc Custoza, che fa riferimento all’areale localizzato nella parte sud-occidentale dell’anfiteatro morenico del Garda, su colline originate da depositi glaciali avvenuti nel Pleistocene che si sviluppano per 1400 ettari sul territorio di 9 comuni: Sommacampagna, Sona, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Pastrengo e Bussolengo. A sud ovest la zona è delimitata dal fiume Mincio.
Il paesaggio è disegnato da una fitta serie di colline allungate, con andamento prevalentemente dolce e dislivelli compresi tra i 50 ed i 100 metri. La pedologia deriva dal ritiro dei ghiacciai che formarono il vicino lago di Garda, originando suoli con matrici molto differenti: leggeri e sciolti, ricchi di scheletro, intervallati da ampie piane ghiaiose e tipici depositi sassosi ben levigati che garantiscono un perfetto drenaggio dell’acqua. Fondamentale è la grande ricchezza di calcare, capace di connotare in maniera palese i vini del territorio, in quanto a freschezza e sapidità. La base ampelografica della quale possono disporre i produttori del Custoza DOC deve contemplare, per un minimo del 70%, i seguenti vitigni: la Garganega, il Trebbianello (un biotipo locale del Tocai friulano, corrispondente al francese Sauvignonasse), il Trebbiano e la Bianca Fernanda (un clone locale del Cortese). Ognuna di queste non può superare il 45%. Il disciplinare di produzione prevede inoltre la possibilità di utilizzare altri vitigni fino a un totale del 30%, quali Malvasia, Riesling, Pinot bianco, Chardonnay e Incrocio Manzoni 6.0.13.
A dare un rapido sguardo a questo elenco di vitigni anche un neofita potrebbe iniziare a chiedersi se non si tratti di una lista di “ingredienti” troppo ampia per delineare una specifica identità con coerenza e riconoscibilità. Dubbio lecito ma che tende a dipanarsi rapidamente assaggiando i vini dell’areale in batteria, come mi è capitato di fare più volte quest’anno (con sessioni che hanno contemplato un numero importante di vini), riscontrando dei marcatori territoriali comuni che rendono la vasta tavolozza di colori un’opportunità per dipingere con, sì, più sfumature ma, al contempo, con un tratto distintivo, fine, sicuro e per nulla grossolano, i profili di queste colline. Un’occasione quindi, e non un limite, la base ampelografica del Custoza ma che ha visto, negli anni addietro, qualche interpretazione tesa a fuorviare dall’identità territoriale che, invece, oggi, può e sa raccontarsi in maniera oculata, andando a rendere onore alle matrici pedologiche locali e alle particolari condizioni climatiche che rendono possibile la produzione di vini di grande equilibrio tra struttura e acidità, con escursioni termiche che ben esaltano gli spettri aromatici di vini che vedono nel loro biglietto da visita olfattivo un fattore determinante.
Interessante anche l’approccio agronomico ragionato e orientato alla sostenibilità promosso dal Consorzio che, da quasi quarant’anni, dispone di un’apposita commissione fitosanitaria costituita da agronomi esperti che stimola l’adozione di tecniche di difesa integrata che privilegiano metodi di coltivazione biologici ed ecosostenibili. Questo ha portato la denominazione a raggiungere più di un quarto (in crescita costante) della produzione certificata biologica, SQNPI o Biodiversity Friend.
Capitolo dolente è il posizionamento che, come capita in molte denominazioni (ancor più se bianchiste) italiane, è livellato verso il basso da una base commerciale orientata, da pochi, ancora troppo sulla quantità e meno sulla qualità. I dati degli ultimi anni, però, fanno ben sperare in quanto la rivendicazione della tipologia “Superiore” è in costante crescita, indice di una volontà sempre più diffusa di alzare l’asticella e raggiungere un posizionamento più consono e gratificante, nonché più sostenibile, in particolare per le realtà medio-piccole. E’ proprio grazie al Custoza Superiore Doc che si percepisce chiaramente un cambiamento in atto nella forma mentis dei produttori locali e questo non può che essere un valido motivo per puntare su un areale che può spiccare per consapevolezza tecnica e per una rinnovata identità territoriale.
Roma Doc – Ben più che una trovata di marketing!

Chiudo con la mia scommessa più ardita (che per qualcuno potrà sembrare una provocazione ma per me non lo è affatto) ma anche con uno dei territori che di più mi hanno sorpreso quest’anno, contraddicendo in maniera chiara e concreta le voci che assimilavano questa giovanissima denominazione a una mera iniziativa commerciale priva di contenuti reali. Parlo della Doc Roma.
Pur essendo il fulcro storico delle viticoltura italiana, nonché uno degli areali più vocati in quanto a condizioni pedoclimatiche, fertilità dei suoli, varietà e duttilità ampelografica e variabilità altimetrica, quella del Lazio rischia, spesso, di essere percepita come una regione poco appetibile per appassionati e addetti ai lavori. Eppure, è proprio qui che un manipolo di virtuose e lungimiranti realtà vitivinicole hanno pensato di rievocare i fasti enoici dell’antica Roma, attraverso un’operazione che sembra assurdo non sia stata realizzata prima. La creazione della DOC Roma, denominazione d’origine che non deve far pensare a una mera trovata commerciale, in quanto pregna di valori territoriali di sicuro interesse.
La DOC Roma si estende su un’area caratterizzata da una grande varietà di territori. Le colline e i monti che circondano la città di Roma offrono diverse tipologie di suolo e microclimi, che conferiscono originalità e peculiarità ai vini prodotti. Si tratta di una vasta area geografica sita nella parte centrale della regione, che comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della campagna romana in provincia di Roma.
La formazione dell’area circoscritta alla produzione di vini Roma Doc risale al Quaternario (o Neozoico) e si divide in due unità geologiche: le aree pianeggianti della valle del Tevere e dell’Aniene, in cui si trovano i sedimenti marini costituiti da un substrato di sedimenti alluvionali. L’area interna determinata dalle eruzioni del Vulcano laziale, risalenti alla fine del Pliocene, nella quale i terreni sono composti da vari tipi di tufo a cui si sono sovrapposti ceneri e lapilli depositati in strati di notevole spessore e cementati in misura diversa. In generale si tratta di suoli molto drenanti, particolarmente adatti alla coltura del vigneto. L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 0 e i 600 m s.l.m., con pendenza variabile; l’esposizione generale è orientata verso ovest, sudovest e sud. Pendenze ed esposizione sono due elementi fondamentali alla determinazione di un clima arioso e luminoso, garanzia di uno sviluppo sano e ricco delle uve che concorrono alla produzione dei vini Roma Doc. Il clima è di tipo temperato-mediterraneo ed è caratterizzato da precipitazioni medie più copiose nelle zone più alte. Le temperature sono più alte nei mesi luglio, agosto e più basse da novembre ad aprile, con escursioni termiche importanti nelle zone collinari. Fattori questi che determinano lo sviluppo degli aromi del vino e che fanno della zona delimitata alla produzione di vini Roma Doc un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.
Nella DOC Roma, i vitigni autoctoni e internazionali si fondono armoniosamente per produrre vini di grande fascino. Tra i vitigni tipici a bacca bianca spicca la Malvasia Puntinata (o del Lazio), ma anche la Malvasia di Candia, il Trebbiano Verde (Verdicchio), il Bellone (Cacchione nel nettunese), il Bombino, il Greco b., il Trebbiano giallo e le internazionali Viognier, Sauvignon e Chardonnay. Mentre tra le varietà a bacca nera, oltre ai tipici Montepulciano, Sangiovese e Cesanese (di Affile e “comune”), i produttori possono contare su una buona disponibilità di Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot e altre varietà internazionali. Se questa è la base ampelografica territoriale in grandi linee, queste sono le tipologie che possono fregiarsi della denominazione “Roma Doc”: sette di vino bianco (“bianco”, “Classico bianco”, “Bellone”, “Classico Bellone”, “Malvasia puntinata”, “Classico Malvasia puntinata”, “Romanella spumante”); due tipologie di vino rosato (“rosato”, “Classico rosato”) e quattro tipologie di vino rosso (“rosso”, “Classico rosso”, “rosso Riserva”, “Classico rosso Riserva). La specificazione “classico” è consentita per i vini della zona di origine più antica, ovvero la più vicina al territorio urbano della Capitale, ad esclusione della tipologia Romanella “spumante” e la versione amabile.
Il mio ultimo focus sull’areale o, per meglio dire, sugli areali della Doc Roma è stato rappresentato da tre giorni intensi e decisamente costruttivi che mi hanno permesso di comprendere lo stato dell’arte e le proiezioni future della denominazione. Una DOC che sta dimostrando di essere ben più di una trovata di markeitng e di avere molti valori intrinseci da poter comunicare, dalla vigna al bicchiere, consci del peso del nome riportato in etichetta. Fondamentale nella comunicazione di questi valori saranno i giovani produttori e vignaioli che, fortunatamente, in quest’area non mancano e sembrano pronti ad agevolare un ricambio generazionale capace di attingere al meglio ci ciò che è stato, scevro da retaggi culturali arcaici che rischierebbero di frenarne la crescita, con una visione più ampia e attuale del mondo del vino in senso stretto e in senso lato.
Per quanto riguarda i vini, è evidente la convergenza interpretativa nei bianchi, specie quando si parla di Malvasia Puntinata (senza dimenticare Bellone e Trebbiano Verde), mentre per i rossi la variegata tavolozza ampelografica può e deve divenire un vantaggio solo e soltanto anteponendo l’identità territoriale alle dinamiche varietali.
Come già accennato, nonostante la produzione sia ancora risicata, sarà interessante esplorare il potenziale dei rosati che per vocazione territoriale e vitigni disponibili (in particolare Montepulciano, Cesanese e Syrah) possono sicuramente rappresentare un’opportunità per i produttori locali. In ultimo, ma non di certo per importanza, lo stato dei vigneti che, nonostante le difficoltà del finale di primavera, ha evidenziato una gestione agronomica accorta ed efficace con un virtuoso contenimento della peronospora (molti dei vigneti visitati erano in bio). Un territorio capace di coniugare numeri e qualità, valori e attitudine commerciale, attraverso una gestione virtuosa a 360° e un rinnovato orgoglio che si percepisce in ogni singolo produttore, motore primario per svincolarsi da preconcetti e cadute di stile ormai relegate al passato.
In conclusione quello della DOC Roma è un territorio vitivinicolo che merita di essere visitato e apprezzato per la sua storia, la sua cultura e i suoi vini degni compagni delle eccellenze gastronomiche locali ma anche capaci di grande versatilità in termini di abbinamento a livello nazionale e internazionale. Quella che si respira, oggi, nelle realtà del territorio è una giusta commistione di tradizione e innovazione, volta a valorizzare in maniera nitida, pulita e determinata le personalità distintive di ogni zona e di ogni varietà in maniera individuale o negli equilibrati blend di territorio. Credo che le dinamiche commerciali e di comunicazione legati all’utilizzo del nome della città eterna in etichetta non possano e non debbano diventare un limite o un freno per la ricerca della qualità e per la possibilità di anelare a una percezione più alta dei vini locali. Proprio per questo sarà fondamentale avere una scala di valori più orientata verso l’alto, con selezioni e “riserve” che ricalchino un posizionamento più gratificante per i produttori e per la denominazione stessa, che altrimenti rischierebbe di cadere nella “sindrome del turista”, nota per provocare una stasi nei territori che ne sono “afflitti”. Per intenderci, se si vende tutto troppo facilmente ma solo a un target parzialmente o totalmente “errato” e livellato verso il basso in termini di contezza enoica e di percezione della qualità, non si sente l’esigenza di migliorare e di alzare l’asticella sia in termini qualitativi che di posizionamento. E’ proprio l’enoturismo, infatti, a rappresentare un’opportunità per la valorizzazione diretta di un’area così ricca di storia e cultura, nella quale i vigneti coesistono con testimonianze archeologiche, come le antiche rovine romane, i castelli medievali e le ville rinascimentali. Uno scenario di sicuro impatto, anche per un viaggiatore avvezzo alla bellezza dei contesti vitivinicoli quale sono, ma non deve diventare un vincolo troppo forte con il passato.
La DOC Roma, infatti, può fare di tale bellezza e suggestione un’arma vincente per l’enoturismo di qualità, accogliendo i visitatori con esperienze di livello che non sfocino nella banalità e nella ridondanza, bensì offrano molteplici opportunità sia in termini di visite in cantine che di degustazioni guidate. Di certo avere Roma come riferimento principale non può che aiutare in questi termini ma non sempre la facilità di accesso a una grande mole di visitatori si rivela necessariamente un volano per l’innalzamento della qualità.
Anche quest’anno ho provato a consigliare territori che hanno manifestato uno slancio particolare verso l’innalzamento della percezione delle proprie peculiarità pedologiche e climatiche, attraverso il lavoro coeso e lungimirante di chi lavora in vigna e in cantina, con un occhio alla sostenibilità e un altro alla ricerca di una traduzione credibile e coerente delle singole identità e dei loro comuni denominatori. La scelta è ricaduta su aree molto diverse fra loro per dimensioni/volumi, contesti sociali ed economici, appeal commerciale e trascorsi e ciò in cui confido è che queste diversità diano un’idea tanto sfaccettata quanto completa di un’Italia del vino che, che di se ne voglia, non smette mai di offrire occasioni di approfondimento degne di soddisfare anche la più acuta curiosità. Inoltre, queste aree si sono dimostrate in grado di contenere (chi più chi meno) gli esiti potenzialmente negativi di un’annata complessa come la 2023.Anche per questo valgono un viaggio di approfondimento da parte di appassionati e addetti ai lavori.
Da par mio, la mia ricerca continua e ho già pianificato gran parte dei viaggi che farò nel 2024 con l’obiettivo di essere stupito ancora da terre e genti che meritano di ricevere ben più della mia sola attenzione.
F.S.R.
#WineIsSharing

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.